
BREVE PRONTUARIO DEL GIOCO: CONOSCERE PER GIOCARE BENE A GIOCARE
- Beatrice Stocco
- Cresci con me
- Visite: 2261
La scorsa settimana ci siamo dedicati a scoprire cosa renda un gioco tale e ad individuarne le principali fasi di sviluppo durante la crescita. Ci siamo lasciati però, con una promessa, quella di condividere una sorta di prontuario che possa esserci utile nella vita di tutti i giorni per chiarirci le idee circa il come giocare, quanto e quando farlo, con i nostri figli. Lo so, lo so, me ne rendo conto: la mia è una intenzione ambiziosa. Quando si parla di gioco si scoperchia un vaso di Pandora fatto di emozioni, significati, esperienza, pensieri e tanto altro, e avanzare la pretesa di scriverci su un prontuario non è cosa da poco. Allora mettiamola così: ho il piacere di condividere con voi alcuni spunti per conoscere meglio il gioco ed il giocare ed in questo modo per migliorare il nostro stesso modo di giocare con i bambini.
…bene, è tempo di cominciare.
I principi del gioco e del giocare
- GIOCARE NON È IMPORTANTE
…GIOCARE È INDISPENSABILE.
“È solo un gioco” è un’espressione che tutti abbiamo ascoltato, o addirittura che abbiamo espresso. Culturalmente il gioco è soggetto a numerosi pregiudizi, tutti di ordine svalutativo, come ne sono esempio le espressioni riportate. Spesso siamo portati a pensare sia inutile, e in qualche occasione addirittura inopportuno e sconveniente. Immagino abbiate intuito che questa premessa serve esattamente a smentire tutto ciò. Per farlo, comincio con il dirvi che tutti giocano. Ma proprio tutti! E si, pure tu che stai leggendo! Il gioco non è solo dei bambini, anche se è pur vero che sia la loro specialità. Il gioco si evolve, modifica, trasforma, ma ci accompagna per tutta la vita. È un bisogno primario. Solo gravissime limitazioni patologiche impediscono di giocare, ma sono talmente rare che è difficile incontrarne.
- SI GIOCA: NON SI IMPARA E NON SI INSEGNA A GIOCARE
Appurata l’importanza del gioco per una buona crescita, e acquisita ormai culturalmente questa consapevolezza, è importante sottolineare come non si impari a giocare, ma si giochi. Pertanto, non è possibile pensare di insegnare a giocare. Si può trasmettere un gioco, condividere, illustrare, spiegare le regole, fornire gli strumenti, ma il gioco si struttura a partire dal contributo personalissimo e prezioso di ogni partecipante. Si imparano le regole, si imparano i tempi, si imparano ad usare gli strumenti e gli oggetti in modo funzionale, ma non si impara a giocare. Il gioco è una capacità innata, dettata da un bisogno primario. Per questo…vedi il prossimo punto.
- NON A QUALE GIOCO SI GIOCA, MA COME SI GIOCA
Non esistono giochi migliori di altri. Non ci sono classifiche, non ci sono livelli. Pertanto…non ci devono essere giudizi! Nicolodi in particolare inquadra degli elementi di riferimento in grado di fornirci importanti indicazioni rispetto al gioco, e fra questi non compare il contenuto. Perché non è tanto importante a quale gioco giochi il bambino, ma come giochi!
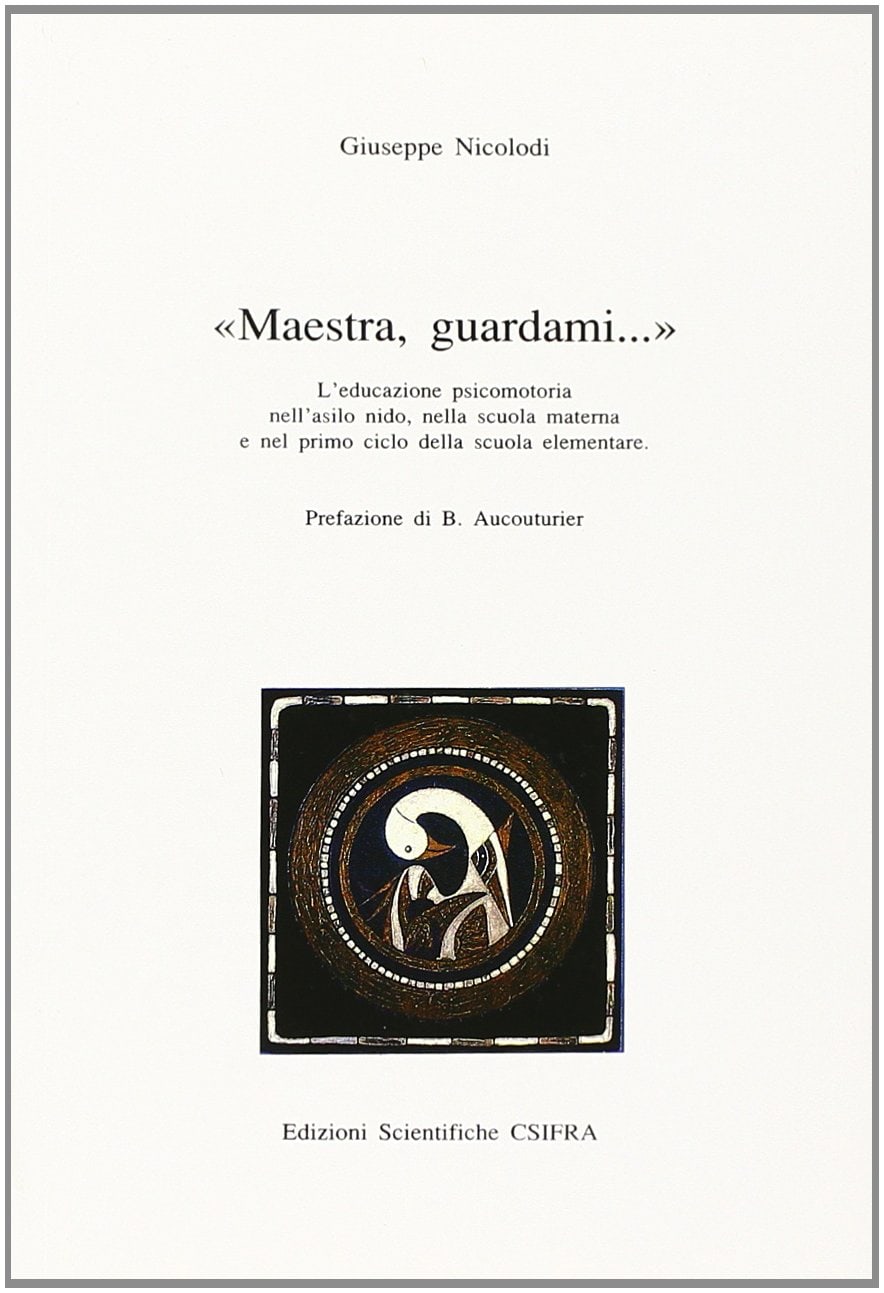
Nicolodi, per merito, Psicologo, psicomotricista, terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, è autore del meraviglioso e preziosissimo “Maestra, guardami!”, di cui consiglio la lettura, anche se sei “solo” genitore e non insegnante. Eccolo: https://www.amazon.it/guardami-Leducazione-psicomotoria-nellasilo-elementare/dp/8886084005.
- senso
- uso del corpo
- emozione
Sono questi i tre elementi che il grande esperto cita, ed essi devono essere ben bilanciati per garantire un buon gioco.
- NON SI GIOCA PER IMPARARE
L’apprendimento rappresenta un elemento imprescindibilmente e profondamente correlato al gioco, ma non ne rappresenta affatto lo scopo ultimo. Il bambino gioca per giocare! Si, proprio così: il gioco non ha scopi ultimi di per sé, intesi da parte del bambino. Il bambino gioca perché il gioco rappresenta per lui un bisogno primario ed essenziale. In un secondo momento è doveroso affermare come attraverso il gioco il bambino apprenda, rielabori esperienze ed emozioni, sviluppi competenze immaginative, attentive, cognitive ed anche emotive, ma non è di certo questo a rappresentare il motivo per cui intraprende un gioco! Tali aspetti sono funzioni del gioco che rendono lo stesso così importante e che lo fanno diventare bisogno primario del bambino, ma non è di certo perché ha voglia di imparare a muoversi meglio, a stare più attento, a gestire meglio le proprie emozioni che un bambino inizia un gioco! In estrema sintesi, rendendo tutto molto più semplice: il bambino non gioca per imparare, ma giocando impara. Inevitabilmente. C’è una grossa e significativa differenza.
- GIOCARE AI CATTIVI SI PUÒ…E SI DEVE
“Non giocare così che sei cattivo”, “questo è un gioco brutto”, “non si gioca alla guerra”. E perché no?
Spesso i giochi con contenuti aggressivi del nostro bambino e dei nostri alunni ci spaventano e ci portano ad imporre delle limitazioni o ad interrompere le sequenze stesse. Ma risiede una profonda e significativa differenza fra gioco aggressivo e gioco violento. Un gioco violento è da impedire in quanto può rappresentare un rischio per il soggetto promotore e per gli altri. Un gioco aggressivo no. E dove sta la differenza, vi chiederete voi? È una questione linguistica, apparentemente, ma di fatto è indispensabile per classificare due modalità di gioco nettamente differenti. È da ritenersi violento un gioco attuato con il deliberato intento di ledere o ferire l’altro o l’oggetto o l’ambiente. Ex: giocare a lanciare i sassi contro le finestre allo scopo di romperle, o nella piena consapevolezza della conseguenza possibile della propria azione. Un gioco aggressivo invece si configura per modalità che possono apparire simili, talvolta difficilmente distinguibili da quelle tipiche della violenza, ma che sono condotte senza l’intento di ledere o ferire o provocare danno. Ex: giocare alla lotta, alla battaglia, al duello. È chiaro come la differenza risieda nell’intenzione e nello scopo ultimi delle azioni.
Non temete i giochi aggressivi: sono importanti! I giochi aggressivi non promuoveranno condotte violente, ed anzi: saranno strumento per apprendere a gestire in modo ottimale i propri impeti aggressivi, la propria rabbia, la propria tonicità corporea, in una dimensione attenuata di finzione, in una cornice protetta dai confini della fantasia e dell’immaginazione.
A determinare un incentivo nella comparsa di comportamenti realmente violenti invece è l’esposizione a condotte altrettanto violente, come per esempio assistere ad atti violenti compiuti da altri su terzi o su oggetti o sull’ambiente.
- MENO GIOCATTOLI…PIÙ CORPO, PIÙ SPAZIO, PIÙ MOVIMENTO, PIÙ OGGETTI SEMPLICI E REALI!
Il mercato ci fornisce una vastita pressochè infinita di giocattoli di tutti i tipi. C’è da dire che molti di essi risultano molto accattivanti: colori, suoni, luci ed effetti, meccanismi e pulsati…a volte fanno divertire più noi che loro. Non è così? Ma è proprio qui il limite più grande di questi oggetti: sono giochi che si fanno da sé! Per noi adulti può essere piacevole apprezzare il complesso funzionamento di un meccanismo e immaginare il lungo processo ingegneristico che ha portato a brevettare questo piuttosto che l’altro ingranaggio…ma per un bambino rimane pur sempre un semplice pulsante che una volta schiacciato produce un effetto. Si, magari è un effetto variabile, ma in poco tempo un piccolo esaurirà la gamma delle variabili e non troverà ulteriore piacere nella scoperta, decretando un apprezzamento parziale e non permettendo di “metterci del proprio”. Gli oggetti semplici, non strutturati, invece, offrono un largo spazio d’azione. Basti pensare in quanti modi si può trasformare un semplice contenitore…una tana, un cappello, un sarcofago, ma anche un mostro, un tesoro…
“I giochi sofisticati sono belli, seducenti, quasi perfetti;
questa perfezione, però, indebolisce la fantasia dei
bambini, perché non è necessario utilizzarla per giocarci”
(Rossini, Urso)
Offrendo così tante opportunità, però, gli oggetti non strutturati allo stesso tempo avanzano grandi richieste al bambino: richiedono di mettere del proprio, di impegnarsi, di attivare la memoria, l’attenzione, di gestire variabili diverse, di attribuire un significato simbolico ed immaginativo…quindi insomma, sembrano noiosi e poco versatili, ma ci permettono di scoprire mondi e soprattutto di attivare mente…e cuore.
Allo stesso modo lo spazio acquisisce un valore straordinario nel gioco, perché elemento indispensabile nel quale il movimento può trovare espressione di sé, e di tale aspetto abbiamo appreso l’importanza: vedi punto 3!
Permettiamo ai bambini di essere liberi. Libertà di essere ciò che vogliono e sentono. Ogni bambino non sa ancora come sia, e per questo vorrà essere come gli altri, come chi ama, come chi stima, come chi ritiene autorevole. Solo nella libertà imparerà ad essere diverso da tutti questi. Ed in questo modo sarà sé stesso.
- NON SEMPRE SI GIOCA: LA NOIA È UN GIOCO IMPORTANTE
Ci è capitato di sentirci chiedere dai nostri bambini che gioco fare, in quanto sforniti di idee, annoiati, senza iniziativa in quel momento. E se ci pensiamo bene, forse, è capitato anche noi quando eravamo alti come loro, qualche anno fa. Cosa fare?
Vi invito a riprendere il punto 2: non si insegna a giocare. Certo, sarà sempre una buona cosa offrire uno spunto, una proposta, un’idea, che si tratti di un gioco individuale o ancora meglio, da fare assieme, da condividere! Ma non abbiate timore a regalare un po’ di noia ai vostri bambini. Non si tratta di un errore, no, ho scritto regalare perché la noia sarà un dono per i vostri bambini. Magari non esattamente quel tipo di dono che richiederemo con affetto e speranza a Babbo Natale e nemmeno agli zii per il compleanno, ma sarà l’occasione di vivere un tempo vuoto, sgravato da qualsiasi schema ed aspettativa, da qualsiasi richiesta e proposta, senza termini. Non sa cosa fare, non saprà a che gioco giocare, ma si guarderà negli occhi e vedrà sé stesso.
A cura di Beatrice Stocco


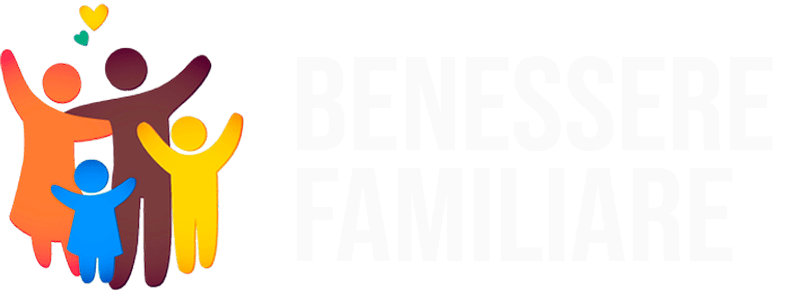

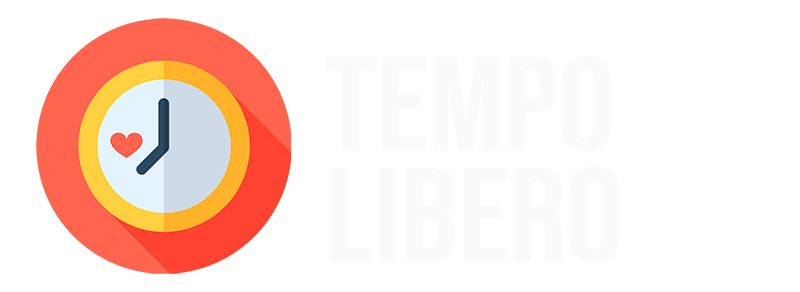


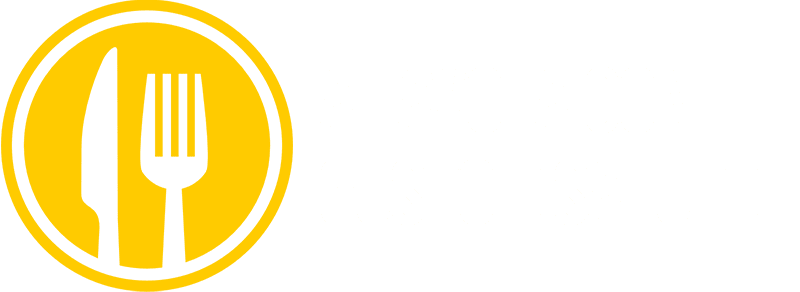

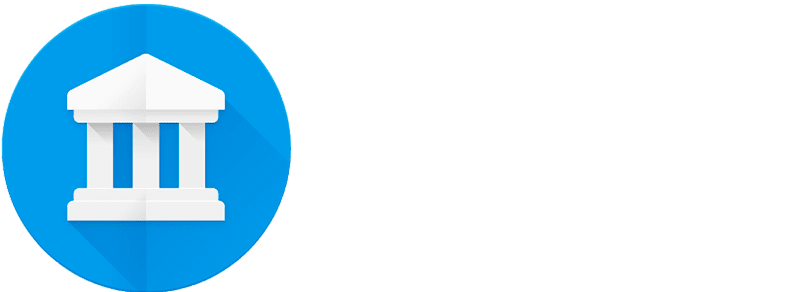

 Assessorato alla Cultura
Assessorato alla Cultura
